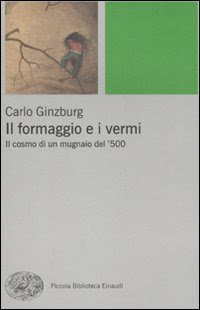|
| Immagine presa da qui |
E' stata una battaglia rispolverata negli ultimi tempi e, in poco tempo, abbandonata. Non è una questione semplice da "cavalcare" perché il potere del linguaggio e del testo scritto sono sempre stati complicati da raccontare con gli strumenti, le parole, che ne sono parte integrante. Innanzitutto è necessario tener presente che bisogna affrontare la questione da più punti di vista: quello di *colui che deve trasmettere un messaggio* e quello *di chi recepisce*, il *valore oggettivo* o *quello soggettivo* che la summa dei vocaboli scelti e messi insieme in un concetto riescono a trasmettere nell'atto della comunicazione. Ce ne sono altri ma, in questa sede, non concorrono all'obiettivo di esporre il *peso* del libro in questione.
La parola ha un valore assoluto di per sè, ma contestualmente "l'insieme delle parole", "l'intonazione" con la quale si pronunciano e il "contesto" in cui vengono dette, nonché l'insieme del vocabolario che un individuo (che sceglie la loro combinazione per esprimersi) possiede, fanno assumere ai vocaboli sfumature molto differenti da quelli che possono essere i *valori* dei singoli vocaboli. Spieghiamo meglio il concetto: ne "La manomissione delle parole" (prima di correre a comprarlo leggete attentamente la recensione!!) Carofiglio spiega ciò che ho appena scritto con un esempio abbastanza semplice. Laddove l'individuo non riesce ad esprimere i propri stati d'animo, subentra la frustrazione e quando questa aumenta si arriva alla violenza; quindi la formazione, cessa di essere mera educazione fine a se stessa e diviene altro, ovvero non solo l'educazione alla civiltà delle masse ma soprattutto un mezzo per fornire alle persone gli strumenti utili per affrontare una civiltà fondata sul linguaggio e l'informazione, mezzi di comunicazione predominanti insieme ai numeri, sulla musica e sul linguaggio figurativo in qualsiasi forma quest'ultimo si presenti (pittura, scultura, arte, danza, etc...). Ma non è sempre stato così.
Torniamo indietro nei secoli scorrendo le lancette del tempo e andiamo nel periodo più oscuro dell'Europa, ma soprattutto italiano, ovvero il periodo del Concilio di Trento (iniziato nel 1545 e terminato con ritardi, rinvii e spostamenti di sede, sempre a Trento nel 1563) e della successiva azione di Controriforma della Chiesa Romana.
Nonostante si sia in piena epoca moderna e si sia usciti già da un po' dal periodo medievale le classi sono ben distinte. C'è l'aristocrazia, il clero e il popolo. L'Italia è divisa non solo politicamente (i Doria a Genova, i Medici a Firenze, gli Spagnoli nei regni di Napoli, Sicilia e Sardegna, gli Sforza a Milano, a Venezia la Serenissima e i grandi possedimenti papali che ospitano al loro interno gli Este a Ferrara e i Gonzaga a Mantova) ma anche linguisticamente ovvero, anche all'interno di uno stesso territorio possono sussistere volgari diversi, derivati non solo dalla lingua latina ma anche dal sottostrato della lingua dei popoli conquistati e il superstrato dei successivi conquistatori (che generano un linguaggio diverso nella loro combinazione nei secoli). Questo significa non solo difficoltà di capirsi, ma anche differenti modi di vedere e di affrontare la vita e diverse tradizioni. In questo stato di fatto, i popoli italiani hanno pochi fattori comuni fra loro; uno è la comune derivazione dall'antico impero di Roma e l'altro è la fede.
1499, Venezia, viene pubblicato il primo libro stampato in Italia (per chi fosse curioso l'editore era Aldo Manuzio e il libro "Hypnerotomachia Poliphili" un romanzo allegorico con una commistione abbastanza ardua da tradurre fra volgare e latino). La macchina e la tecnica per la stampa era già arrivata precedentemente portata dai frati nella zona del territorio lombardo e qualcosa era già stata data alle stampe ma il 1499 segna una svolta per l'editoria e Venezia si configura come la capitale degli editori. Fino ad allora e subito dopo questa tecnica innovativa trova estrema difficoltà per decollare in maniera compatta. Tre tipi di forze si oppongono al suo sviluppo:
1499, Venezia, viene pubblicato il primo libro stampato in Italia (per chi fosse curioso l'editore era Aldo Manuzio e il libro "Hypnerotomachia Poliphili" un romanzo allegorico con una commistione abbastanza ardua da tradurre fra volgare e latino). La macchina e la tecnica per la stampa era già arrivata precedentemente portata dai frati nella zona del territorio lombardo e qualcosa era già stata data alle stampe ma il 1499 segna una svolta per l'editoria e Venezia si configura come la capitale degli editori. Fino ad allora e subito dopo questa tecnica innovativa trova estrema difficoltà per decollare in maniera compatta. Tre tipi di forze si oppongono al suo sviluppo:
- gli intellettuali sono restii a lasciar andare i propri scritti, la diffusione che potrebbero avere, non solo aumenterebbe la notorietà ma anche anche l'esposizione del loro autore sia alla gloria che ai pericoli di condanna;
- la lingua, perché nonostante la seconda metà del 400 sia stata preparatoria alla stampa sfornando studiosi sia del greco e del latino, contestualmente, è stato dato al dialetto volgare un nuovo peso (è in questo periodo che nascono le prime grammatiche e i primi studi sull'impaginazione e, stupite, anche sul modo di scrivere graficamente perché questo fosse uniformato). E' in questo periodo, più di altri, che ci si domanda quale sia la lingua giusta per la stampa (stampare la divina commedia in dialetto milanese, o romano restituisce il medesimo effetto del volgare fiorentino degli inizi del '300? No!) perchè il primo input di una tecnica come questa è che il prodotto finale possa arrivare a molti e non che sia settorializzata;
- infine e non meno importante, la diffusione, porta cultura e la cultura porta alla ribellione. Quindi la chiesa, che ha sempre usato le leve della fede "ignorante", si trova a dover gestire una possibile catastrofe e lo fa, non solo con la reprimenda pura e semplice attraverso la messa all'indice dei testi giudicati eretici, ma eliminando direttamente i possibili casi "fuori le righe".
In queste maglie cade anche il protagonista della storia che qui è raccontata, Domenico Scandella detto il Menocchio, vissuto in piena epoca della Controriforma tra il 1532 e il 1600 nelle campagne del Friuli. Era un mugnaio e per lavoro aveva dovuto imparare a leggere e far di conto, ma attenzione imparare non significa studiare come noi lo intendiamo oggi. Quello si faceva nelle università o con adeguati precettori privati, che solitamente erano gli stessi intellettuali in voga che così venivano sponsorizzati nelle proprie arti. "Imparare" in questo periodo significa riconoscere lettere e numeri, non elaborare concetti autonomi. La parola, per la classe cui appartiene Menocchio, è un mezzo pratico per segnare quali merci si ha in magazzino e il numero per sapere quanta roba è entrata o uscita. Menocchio conosce anche qualche parola di latino, ma non abbastanza da padroneggiare la lingua che appartiene al clero e agli studiosi; ha ricoperto piccole cariche gestionali nel paese in cui vive e nel quale opera e possiede due mulini e detta fra noi non se la passa nemmeno tanto male, ma manca qualcosa ed è un tarlo che continua a scavare quel legno che si forma nella coscienza dei suoi compaesani e che integro permette loro di non domandarsi nulla ma solamente sopravvivere. Menocchio si interroga e anche tanto, sente che gli manca qualcosa. Perché siamo qui, dove stiamo andando, chi siamo rispetto a Dio e rispetto agli altri e soprattutto chi ha creato quest'ordine strano che permette a molti di essere servi dei pochi che campano come zecche sul lavoro della povera gente. Quindi questo tarlo poggia sulla realtà sopra citata, da una parte è politica e dall'altra è religiosa e anche un pochino filosofica. Tramite conoscenze, anch'esse "fuori dalle righe", quindi in incontri che potremmo dire "fortunati" (anche se ne hanno decretato non solo la sofferenza interiore ma anche e soprattutto la morte), Domenico scopre che i libri dicono molto più di quel che si pensi. Non sono solo prontuari di lavoro o raccolte di preghiere o di storie della Bibbia, i libri sono anche luoghi in cui trovare dei "punti di vista" e forse a suo pensiero qualche risposta.
A Menocchio, però, manca una cosa abbastanza importante; ha i libri e riconosce le parole ma non ha gli strumenti per metterle in connessione e mettere i concetti, che ne vengono fuori, a confronto con il proprio giudizio e con quello altrui per confrontare e capire sé stesso e se la direzione che sta prendendo può avere ulteriori declinazioni. Al tempo stesso, Ginzburg rimarca, che Domenico Scandella non riesce a prendere completamente un concetto valutandolo nella sua interezza ma si fissa solo su un'unica parola o sfumatura declinandola all'infinito e giungendo a conclusioni a volte tra loro contraddittorie. Una di queste in particolare, sarà motivo di condanna, sia della prima che della successiva (che ne sentenzia la morte): il rapporto fra uomo e Dio.
Dio e gli angeli, quando hanno fatto il mondo (già così si mina l'onnipotenza di Dio perché ha avuto bisogno degli angeli!) hanno lavorato come si fa il formaggio, ovvero la massa si raggrumata come il formaggio con il caglio e l'altissimo con gli angeli hanno lavorato come fanno i vermi. Di qui il nome del libro "Il formaggio e i vermi", la definizione fa un po' senso ma è perfettamente pertinente. Il formaggio cagliato in fondo non ha un sapore particolare, ma per diventare "caratteristico" ha bisogno di stagionatura o della creazione di quelle muffe che lo rendano piccante o dolce o che lo conservino cremoso all'interno. Quindi se Dio e gli angeli non avessero operato in siffatto modo, la terra sarebbe rimasta un ammasso vuoto.
Ma, dal punto di vista di chi giudica in quel periodo, il paragone Dio-vermi non è una scelta felice. E torniamo all'incipit di questa recensione ovvero il *valore dell'informazione* che rappresenta soggettivamente per Scardella "la formazione del mondo e la sua caratterizzazione" si scontra con quella *accettata e asservita* degli inquisitori che non vogliono e forse non sono nemmeno in grado di analizzare il punto di vista, se non utilizzando cavilli lessicali che nulla hanno a che vedere con l'elaborazione del concetto, ma solo con la *giustificazione* dello stesso.
Menocchio finisce sotto inchiesta per denuncia. All'epoca la denuncia è un mezzo anche di regolazione di conti e non meno di eliminazione degli avversari o elusione dei controlli, e diciamocelo in questo, la natura umana contemporanea non è poi molto cambiata.
Ma nel caso di Scandella l'odio nei confronti del parroco del paese, viene anche supportato dalle dichiarazioni impaurite dei compaesani. Perché Domenico non si limita a pensarle queste cose, ma le vuole anche condividere, così ad uno dice che la confessione è un fatto privato che si deve imparare a gestire in maniera autonoma imparando la legge divina e che il clero non è altro che un mezzo di oppressione che fa leva con la religione per annientare e gestire le coscienze del popolo. Ad un altro invece dice che se l'uomo è creato da Dio come anche le cose della terra, in fondo, noi siamo una specie di ulteriore *elemento* di questo cosmo insieme con acqua, terra, fuoco e aria; che la nostra natura non può nascere cattiva e ad altri annuncia che, nel caso gli verrà richiesto, ne andrà a parlare con le più alte cariche che vorranno saperne di più denunciando la propria frustrazione di non incontrare nei propri compaesani possibilità di confronto. Quindi se ritorniamo e confrontiamo l'asserzione oggi valida per noi, che la frustrazione è frutto della mancanza di vocaboli, all'epoca del Menocchio la frustrazione è invece dovuta non solo alla scarsità delle informazioni (pertinente a quello che succede anche a noi che ne siamo soverchiati e abbiamo difficoltà a selezionare quelle veramente rilevanti) ma, anche, dalla difficoltà prima dell'elaborazione di concetti autonomi e poi del confronto e della verifica del proprio punto di vista. Quindi all'epoca non bastava possedere solo *i vocaboli*.
Quel che Domenico Scandella non sapeva, è che il *confronto* con le alte cariche che lo mettono sotto inchiesta non gli darà in alcun modo la possibilità di verifica. Perchè dall'altro lato del tavolo, ci sono persone che sono in possesso, almeno sulla carta, dei requisiti per poter "andare oltre" ma sono altresì asserviti alla *regola vigente* quindi il confronto è fra muti che *parlano* con i sordi e, in fondo, il giudizio è solo un pretesto, per l'eliminazione dell'eretico dal gruppo o per condanna o per prigionia, fattori che in modi diversi decretavano prima o poi la morte (la condanna per Menocchio è veramente dura, ovvero la segregazione prima in prigione e poi, fuori, con il vestire un abito che denunci le sue colpe e che quindi gli impedisce di aver rapporti con chicchessia).
Quindi se dal lato del condannato la *verifica* è sul *concetto*(ovvero Menocchio ha necessità di verificare quel che pensa di aver capito), dall'altro lato, punta l'obiettivo sulla *parola*: Dio->vermi, Fedele->autonomia nel credo, Clero-> mezzo di oppressione e sfruttamento e via dicendo.
Ed è in questo e in un altro punto che l'approccio storico di Ginzburg un po' fallisce.
Questo libro non è solo il suo contenuto, ma anche il racconto di un *approccio metodologico* che, nel novecento avanzato (il libro è del 1976), cerca, nelle storie di uomini comuni, di raccontare la storia *vera* che non è solo al livello dei potenti ma anche in quello degli umili.
In questo modo di vedere la storia in maniera democratica bisogna però tener conto, come rimarca l'autore, che la documentazione ha invece un solo veicolo ovvero quello di chi ha i mezzi per studiare e teorizzare. Quindi il fatto storico non arriva a noi come una "informazione assoluta", ma solo come un *punto di vista* di una voce, quella del potere, e non di tutte. Menocchio non pensa a scrivere la propria autobiografia da lasciare ai posteri, è proiettato al presente e molto probabilmente nemmeno sa cos'è una autobiografia. Quel che sappiamo deriva da atti di giudizio o trascrizioni degli interrogatori, comunicazioni tra prefetti o preti o deposizioni di testimoni più orientati a dichiararsi estranei che a comunicare quel che Menocchio ha realmente fatto o detto.
L'errore secondo me sta nel non rimarcare che la mancanza di Domenico Scardella nel non riuscire a comprendere un "concetto nella sua totalità" è pari, ma meno colpevole, di quella mancanza, da parte di chi giudica, di staccarsi dal significato delle singole parole (e quindi di *recezione dei concetti*) che solo in parte può essere giustificata con la necessità di sopprimere comunque qualsiasi comportamento eversivo. L'altra mancanza è l'elusione, forzata che dimostra il limite del metodo.
Quel che viene fuori è che Menocchio ha ben presente cosa muove l'uomo. L'uomo è fatto di carne, ossa e di spirito, ed è quest'ultimo che gli da la forza non solo di vivere, ovvero lo spirito è ciò che lo rende vivo ma contestualmente, nel momento in cui manca, l'uomo muore. Lo spirito è un concetto che esprime un'entità quasi autonoma che muove le fila della vitalità umana, che ci è stata donata da Dio, ma che con lui, al momento del rilascio e della generazione di una nuova vita, cessa di essere in relazione con il divino. Concetto che ricorda anche le affermazioni di Dante, ovvero che non è Dio che, in noi, regola le azioni buone e che condanna quelle cattive, ma che bene e male sono frutto della *libera scelta* ("libero arbitrio") dell'uomo che decide se vivere o no secondo i dettami della religione sperando nella salvezza dopo la morte. Ma a Menocchio manca un pezzo. Nella sua ricostruzione mentale della struttura *filosofica* dell'uomo non contempla "l'anima". E' un concetto che non solo non riesce a spiegarsi, ma che non riesce nemmeno a farsi spiegare da chi lo interroga e che nemmeno l'autore è in grado di dire se, alla fine, il Menocchio riesca o no a dare una forma a questo vocabolo "oscuro". Nel corso del libro vengono messi a fattor comune e per gradi tutta una serie di concetti, ricercati nei testi che potrebbe aver letto questo mugnaio intraprendente, ma l'ultima pagina del libro termina con un nulla di fatto. Menocchio muore, ma muore come vuole la sua convinzione, separandosi dallo spirito che lo aveva accompagnato dalla nascita.
Quel che viene fuori è che Menocchio ha ben presente cosa muove l'uomo. L'uomo è fatto di carne, ossa e di spirito, ed è quest'ultimo che gli da la forza non solo di vivere, ovvero lo spirito è ciò che lo rende vivo ma contestualmente, nel momento in cui manca, l'uomo muore. Lo spirito è un concetto che esprime un'entità quasi autonoma che muove le fila della vitalità umana, che ci è stata donata da Dio, ma che con lui, al momento del rilascio e della generazione di una nuova vita, cessa di essere in relazione con il divino. Concetto che ricorda anche le affermazioni di Dante, ovvero che non è Dio che, in noi, regola le azioni buone e che condanna quelle cattive, ma che bene e male sono frutto della *libera scelta* ("libero arbitrio") dell'uomo che decide se vivere o no secondo i dettami della religione sperando nella salvezza dopo la morte. Ma a Menocchio manca un pezzo. Nella sua ricostruzione mentale della struttura *filosofica* dell'uomo non contempla "l'anima". E' un concetto che non solo non riesce a spiegarsi, ma che non riesce nemmeno a farsi spiegare da chi lo interroga e che nemmeno l'autore è in grado di dire se, alla fine, il Menocchio riesca o no a dare una forma a questo vocabolo "oscuro". Nel corso del libro vengono messi a fattor comune e per gradi tutta una serie di concetti, ricercati nei testi che potrebbe aver letto questo mugnaio intraprendente, ma l'ultima pagina del libro termina con un nulla di fatto. Menocchio muore, ma muore come vuole la sua convinzione, separandosi dallo spirito che lo aveva accompagnato dalla nascita.
Quindi, alla fine, anche lo storico rimane un po' sommerso dalle fonti e termina il suo racconto fornendo il punto di vista degli inquisitori e non dell'inquisito almeno per quanto attiene l'anima.
Ironicamente questo libro è metafora del peso della cultura e dei mezzi con i quali si devono affrontare i testi; Menocchio è la dimostrazione non solo che, nella massa asservita, ci sarà sempre chi andrà oltre la cortina creata per lasciarla nell'ignoranza e permetterne lo sfruttamento, ma denuncia anche la necessità primaria dell'uomo per la sua evoluzione, ovvero del confronto, necessario e indispensabile non sono per formarsi una coscienza ma anche un'identità.
Per capirlo, sia il testo nella sua totalità che il caso raccontato nel particolare nelle sue sfumature, va letto con i mezzi della cultura e della comprensione (necessari oggi come ieri ) e quindi, non avere presente il contesto storico o quello culturale, difficilmente permetterebbe di capire la portata dell'evoluzione del pensiero menocchiano in un contesto così povero e il peso di questa sua ansia di de-strutturazione della realtà nei suoi elementi più piccoli per l'analisi e comprensione.
Per capirlo, sia il testo nella sua totalità che il caso raccontato nel particolare nelle sue sfumature, va letto con i mezzi della cultura e della comprensione (necessari oggi come ieri ) e quindi, non avere presente il contesto storico o quello culturale, difficilmente permetterebbe di capire la portata dell'evoluzione del pensiero menocchiano in un contesto così povero e il peso di questa sua ansia di de-strutturazione della realtà nei suoi elementi più piccoli per l'analisi e comprensione.
Questo non significa che non sia da leggere, anzi è un titolo consigliato almeno da me. Bastano pochi elementi come quelli citati e le numerose note o l'introduzione (che vi consiglio di leggere dopo aver letto il testo) per poter avere i mezzi per affrontare questo lavoro minuzioso di ricostruzione della vita di un uomo comune, del popolo. Va anche detto che la commistione di concetti che volta per volta si ricercano nelle dottrine protestanti o ortodosse, devono essere (e credo che siano così state intese dall'autore), prese al netto della religione che le ospita perchè proprio per il suo distacco dal credo; Menocchio stesso è "democratico" a suo modo, ovvero, ricerca quella che è la spiegazione del divino non nel credo altrui ma nell'elaborazione *primitivamente scientifica* dei concetti cristiani e laici e solo in un caso si accenna che possa aver avuto la possibilità di leggere o avere fra le mani un testo religioso al di fuori di quelli del credo cui appartiene ed è il Corano. Perché? Come avveniva ieri per le strade del Friuli o nelle aule dei tribunali, Menocchio ancora oggi, fra le pagine di questo libro, urla la propria *indipendenza di pensiero* e la propria voglia di *capire e far propria una visione* e credo che queste siano la più grande lezione che ci possa aver lasciato. E in questa sfumatura, l'autore di questo libricino è pienamente riuscito nel suo intento ovvero rendere *grande innovazione* ciò che è stato considerato al tempo *piccola sbavatura del sistema vigente*.
Buone letture,
Simona
p.s.: Come già detto nel [Dal libro che sto leggendo], questo testo è uno di quelli a scelta da leggere e portare all'esame di Storia Moderna. Lo avrei probabilmente acquistato autonomamente per la particolarità del titolo ma credo che, se non fosse stato per la necessità, difficilmente sarei arrivata a trovarlo nel mare dei titoli di saggistica legati alla storia.
Simona
p.s.: Come già detto nel [Dal libro che sto leggendo], questo testo è uno di quelli a scelta da leggere e portare all'esame di Storia Moderna. Lo avrei probabilmente acquistato autonomamente per la particolarità del titolo ma credo che, se non fosse stato per la necessità, difficilmente sarei arrivata a trovarlo nel mare dei titoli di saggistica legati alla storia.
Il formaggio e i vermi.
Il cosmo di un mugnaio del '500
Carlo Ginzburg
Einaudi Editore, ed 2009 (è un lavoro del 1976)
Collana "Piccola biblioteca Einaudi"
Prezzo 21,00€